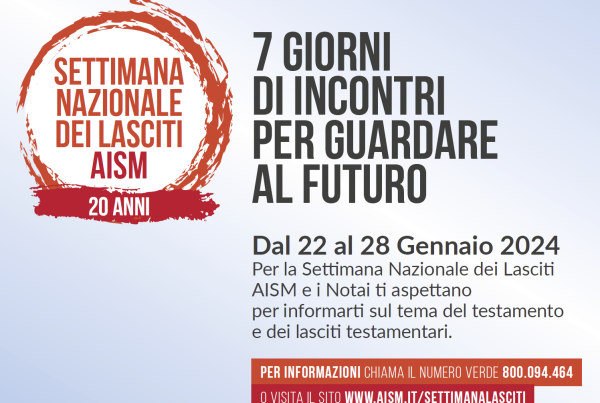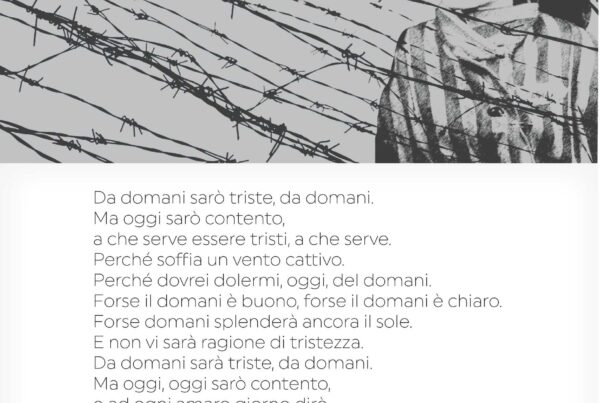DA DOVE PARTIRE PER LA RIFORMA DEL WELFARE
di Chiara Saraceno da La Voce. info
Il welfare italiano è certamente da riformare. Ma occorre farlo in modo coerente, evitando di accentuare la frammentarietà del sistema. Bene introdurre politiche universali di sostegno al costo dei figli e garantire forme di reddito a chi si trova in povertà.
SISTEMA TROPPO FRAMMENTATO
In un rapido accenno nella discussione sul Jobs Act, Matteo Renzi ha annunciato una riforma complessiva del welfare. Che il welfare italiano abbia un urgente bisogno di essere riformato è indubbio, stante che si tratta di uno dei sistemi più frammentati, più pieni di buchi, più esposti a manipolazioni e imbrogli tra quelli europei. Di ambizioni di riforma si parla almeno da venti anni, dalla commissione Onofri istituita dal primo Governo Prodi, senza che se ne sia fatto nulla, salvo i ritocchi a margine, spesso dolorosissimi, varati via via dai vari Governi, che hanno ulteriormente aumentato la frammentazione e i rischi di iniquità. Le analisi e le proposte sono tante e forse, nonostante la sua idiosincrasia per gli intellettuali, non sarebbe male che Renzi e i suoi consiglieri ne prendessero atto, per evitare di inventare l’ombrello, ma anche per comprendere che il sistema di welfare è, appunto, un sistema, che deve (dovrebbe) avere una logica coerente, non un ammasso di frammenti spesso tra loro incoerenti. Soprattutto, lui che è così ossessionato dal peso morto del “vecchio”, dovrebbe liberarsi da una logica puramente lavoristica nel pensare al welfare. Questa logica è stata alla base del welfare come lo conosciamo, e in Italia ancor più che altrove: salvo la sanità, pressoché tutte le politiche sociali sono di tipo categoriale e lavoristico, anziché essere dirette ai cittadini in quanto tali. Ad esempio, non sono mai state sviluppate politiche universali di sostegno al costo dei figli, a prescindere dalla posizione dei genitori nel mercato del lavoro; e non è mai stata introdotta una misura di garanzia di reddito per chi si trova in povertà e spesso non è mai riuscito neppure a entrare nel mercato del lavoro, almeno in quello formale. Segnalo che entrambe queste misure sono presenti nei sistemi di welfare, pur molto diversi tra loro, che sembrano di volta in volta ispirare il nostro premier, i suoi ministri e i suoi supporter: quelli inglese, danese e tedesco, come nella stragrande maggioranza dei paesi europei. E sono date per scontate, soprattutto la seconda misura, insieme alle politiche di conciliazione famiglia-lavoro, anche dalla strategia Europa 2020, che pure è largamente informata da un approccio prevalentemente lavoristico.
LA QUESTIONE DEI LAVORATORI POVERI
Senza queste due misure, l’impianto del welfare che il presidente del Consiglio sembra avere in mente rischia di non aggredire la questione della povertà, che pure, specialmente quella assoluta, in questi anni è drammaticamente aumentata in Italia: nel 2013 coinvolgeva il 7,8 per cento delle famiglie e il 10 per cento degli individui, una percentuale quasi tre volte più alta di quella rilevata nel 2007. Può sembrare un giudizio paradossale. Che cosa c’è di più efficace del lavoro (remunerato) per far uscire dalla povertà? Eppure le cose non sono così semplici. In primo luogo, occorre pensare anche a chi non trova lavoro – e per questo non matura il diritto alla indennità di disoccupazione – perché la domanda è scarsa, perché non ha le qualifiche adeguate, perché ha un carico di lavoro famigliare pesante. È certo opportuno incentivare le persone ad attivarsi, a effettuare la formazione necessaria per collocarsi nel mercato del lavoro, posto che vi sia domanda.
Ma, mentre cercano e si danno da fare e aspettano che la domanda di lavoro aumenti, bisognerà o no pensare a come aiutare loro e le loro famiglie a sopravvivere, specie se chi è senza lavoro è anche chi, in famiglia, sarebbe teoricamente responsabile del mantenimento? In secondo luogo, avere un lavoro non sempre è sufficiente a tenersi fuori dalla povertà. Come ha documentato anche l’ultimo rapporto della Commissione europea su sviluppo e occupazione in Europa, l’Italia è tra i paesi dove più sono aumentati i lavoratori poveri, coloro cioè che sono poveri nonostante lavorino. Ciò non è dovuto solo ai bassi salari o al part time involontario. È dovuto soprattutto alla combinazione tra bassa intensità di lavoro entro la famiglia, ovvero alla forte incidenza di famiglie monoreddito, specie nei ceti economicamente più modesti e nelle famiglie più numerose, e frammentarietà e inadeguatezza dei trasferimenti sociali rivolti a chi è in età da lavoro (indennità di disoccupazione, assegni per i figli, detrazioni fiscali che non tengono conto dell’incapienza). Questa combinazione conferma che le politiche del lavoro e degli ammortizzatori sociali destinati a chi perde il lavoro sono essenziali; ma indica che devono tener conto anche del fatto che le opportunità lavorative, per altro scarse, non si distribuiscono omogeneamente nella popolazione e tra territori. Lo ha documentato anche un recente volume comparativo sugli anni pre-crisi, quando in Europa è aumentato il tasso di occupazione ma non è diminuito quello di povertà, in primis perché non è diminuita la quota di famiglie a bassa intensità lavorativa. Per aumentare l’intensità di lavoro remunerato delle famiglie occorrono sia politiche di investimento sociale dirette ai più svantaggiati, giovani e meno giovani, sia politiche di conciliazione famiglia-lavoro: proprio quelle oggetto di drammatici tagli in periodi di austerity. Ma aumentare il numero di lavoratori per famiglia, posto che ci si riesca in un contesto di domanda debole, non basta. Occorrono anche trasferimenti, in primo luogo diretti a sostenere il costo dei figli minorenni.
Qui l’articolo originale da lavoce.info